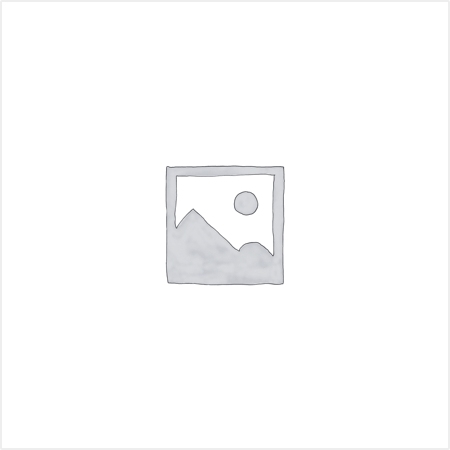Chiamatelo sonno. Perché dobbiamo tornare a dormire
Si muore prima per deprivazione di sonno che per deprivazione di cibo; eppure sappiamo il cibo a cosa serve, mentre il sonno no. Nonostante il mistero che ancora avvolge – almeno in parte – la sua funzione biologica, dalla ricerca scientifica emergono sempre più indizi riguardo il ruolo fondamentale del sonno nel mantenere il benessere dell’individuo, nel corpo e nella mente. Non c’è da stupirsi forse, sapendo che l’essere umano passa circa un terzo della propria vita dormendo e che quasi l’intero mondo animale presenta uno stato fisiologico assimilabile al sonno; eppure, tra il 10% e il 30% della popolazione nei paesi industrializzati soffre di insonnia e ancora oggi la cura dell’igiene del sonno fatica a emergere come una strategia di salute pubblica. La deprivazione di sonno, che sia acuta (ovvero la totale assenza) o cronica (dormire meno delle 7 ore raccomandate, per un lungo periodo), si ripercuote su diverse componenti dell’organismo, associandosi a un aumento delle malattie cardiovascolari e metaboliche, alla riduzione dell’efficienza del sistema immunitario, soprattutto dell’immunità adattativa (la deprivazione di sonno riduce la risposta ai vaccini, minandone l’efficacia), e a un elevato stato infiammatorio sostenuto nel tempo. Questi effetti, associati anche all’eccesso (dormire più di 10 ore a notte), indicano come il sonno sia un fenomeno sistemico, con una funzione eterogenea che coinvolge diversi aspetti della fisiologia umana. Gli effetti maggiori dei disturbi del sonno si manifestano a livello del sistema nervoso centrale, tra problemi di memoria, compromissione dell’equilibrio emotivo e delle funzioni cognitive, e lasciano intendere come il sonno sia “del cervello, dal cervello e per il cervello”(J. Allan Hobson).
Proteggere il cervello: sonno e malattie neurodegenerative
Negli ultimi anni, un crescente numero di evidenze ha scoperto e dimostrato il ruolo neuroprotettivo del sonno per diverse malattie neurodegenerative, come l’Alzheimer, il Parkinson e la Demenza. Il cervello infatti non possiede vasi linfatici in grado di raccogliere e rimuovere gli scarti metabolici delle attività neuronali, ma drena questi prodotti potenzialmente neurotossici attraverso una rete perivascolare di cellule gliali (cellule di supporto del sistema nervoso) che costituiscono il cosiddetto sistema glinfatico Il liquido cerebrospinale che circonda il cervello permea attraverso queste cellule negli spazi interstiziali tra i neuroni, dove fluisce raccogliendo i metaboliti di scarto, e fuoriesce lungo il sistema glinfatico, ripulendo il cervello dalle scorie. Il flusso aumenta particolarmente durante il sonno e si ipotizza che siano in parte proprio le lente oscillazioni dell’attività neuronale, tipiche del sonno profondo, a incrementare il volume e il moto convettivo del liquido cerebrospinale. Questa funzione di clearance (pulizia) dell’ambiente neuronale si ritiene sia fondamentale per diminuire l’accumulo di sostanze neurotossiche come le proteine β-amiloide e Tau, tipicamente responsabili dell’Alzheimer, così come l’α-synucleina del Parkison. In accordo con questi dati, diversi studi hanno osservato che un deficit cronico di sonno è associato a un incremento nell’incidenza di Alzheimer, demenza e declino cognitivo, e correla con la diminuzione del volume, dell’area e dello spessore della sostanza grigia di diverse zone neocorticali e dell’ippocampo.
Tutt’altro che a riposo
Se è intuitivo – e scientificamente dimostrato – che il sonno ha una funzione ristorativa, di risparmio energetico e “pulizia” degli scarti metabolici, l’intensa attività cerebrale che si registra quando un individuo dorme, ha da sempre lasciato supporre che la faccenda non fosse finita lì.
Nonostante la condizione di incoscienza tipica del sonno, dall’addormentamento al risveglio, il cervello modifica la propria attività secondo un ordinato susseguirsi di stati elettrofisiologici caratteristici, che variano con un andamento definito a “oscillazione smorzata”. Quando ci si addormenta e il battito cardiaco rallenta, così come le funzioni metaboliche e il respiro si fa più lento e regolare, l’attività elettrica del cervello, che nella veglia era desincronizzata e ad alta frequenza, inizia a cambiare e sincronizzarsi, passando per gli stadi 1, 2, 3 fino ad arrivare allo stadio 4 di sonno profondo, in cui domina un’oscillazione sincrona e globale dell’eccitabilità neuronale (onde delta); in altre parole, i neuroni del cervello si attivano e si disattivano in maniera coordinata secondo una lenta frequenza di scarica (0,4-3,9 Hz). In seguito, il ritmo cerebrale si modifica di nuovo, ripercorrendo in senso inverso gli stadi 3 e 2, ma al posto di svegliarsi, entra nello stadio di sonno REM, caratterizzato da un’attività cerebrale desincronizzata simile alla veglia, con un aumento nella variabilità delle frequenze cardiache e respiratorie e assenza completa di tono muscolare, tranne per gli occhi, che si muovono rapidamente. A questo punto il ciclo (della durata totale di circa 90 minuti) ricomincia: il cervello torna negli stadi 2, 3 e 4, per poi risalire e tornare del sonno REM, e questa progressione si ripete per circa 6 volte. Nella prima fase, il sonno profondo non-REM prevale, con durate maggiori, mentre con il procedere della notte, la fase REM aumenta, diventando predominante nella mattina. Nonostante la diffusa concezione che il sonno implichi un’attività sincrona globale del cervello, recenti evidenze ottenute grazie a registrazioni intracraniche, hanno dimostrato che diverse aree cerebrali possono trovarsi in diversi stadi elettrofisiologici contemporaneamente, aprendo la strada a nuove teorie sulle dinamiche con cui il sonno svolge le proprie funzioni.
Un sonno per ricordare…
Una delle funzioni classicamente riconosciute al sonno, seppur ancora largamente incompresa, è la facilitazione del consolidamento della memoria. Una buona notte di sonno non solo migliora le nostre performance cognitive, riducendo i tempi di reazione e aumentando l’intelligenza fluida per esempio, ma ha un effetto decisivo sulla nostra capacità di ricordare, in particolare per quanto riguarda i tipi di memoria che dipendono dall’ippocampo, come la memoria spaziale, temporale ed episodica, che riguarda gli eventi che compongono la nostra autobiografia. Di regola, la formazione di una memoria comprende una prima fase di acquisizione, in cui l’informazione viene immagazzinata sotto forma di memoria a breve termine, e un successivo processo di consolidamento, con cui viene tramutata in una memoria a lungo termine. Numerosi esperimenti, sia in modelli animali che nell’essere umano, hanno dimostrato che il sonno è uno stato cerebrale privilegiato in cui le memorie si stabilizzano e consolidano; la domanda che rimane è: come?Caratterizzato dall’estrema riduzione di stimoli esterni, il sonno offre le condizioni ottimali per il consolidamento delle memorie, in parte proteggendole passivamente dalle interferenze dei nuovi stimoli ambientali. Questo semplice fenomeno però non spiega l’impatto che ha il sonno sul consolidamento della memoria, che implica l’esistenza di un meccanismo attivo di facilitazione. A oggi vi sono diversi modelli che teorizzano il meccanismo con cui il cervello guida questo processo, tenendo in considerazione che la memoria stessa è un fenomeno ancora in parte sconosciuto.
Una delle visioni principali (modello del Consolidamento attivo dei sistemi) si concentra sulla trasformazione delle rappresentazioni cerebrali di uno stimolo (ovvero reti di connessioni sinaptiche tra neuroni), che vengono riattivate nell’ippocampo come un replay, e trasferite in parte alla neocorteccia. L’attività dell’ippocampo dirigerebbe i cambiamenti nelle connessioni corticali, dettando quali collegamenti devono essere fortificati e quali indeboliti, così riorganizzando i network della corteccia, che a sua volta disseziona le diverse componenti dell’informazione per astrarne i caratteri comuni e integrarli con le memorie preesistenti.
Questa visione non esclude il modello dell’Omeostasi sinaptica, proposto dagli italiani Giulio Tononi e Chiara Cirelli, per cui il ruolo chiave del sonno sarebbe di ristabilire un equilibrio nella forza delle connessioni sinaptiche, operando un ridimensionamento generale che porta all’indebolimento selettivo delle sinapsi superflue e alla protezione dei collegamenti importanti, secondo un processo competitivo di selezione: solo le sinapsi che costituiscono una rappresentazione di informazioni utili (e quindi collegamenti forti) sopravvivono al ridimensionamento, con un concomitante aumento del rapporto tra segnale e rumore di fondo, che rende più netta la memoria.
… e un sonno per dimenticare
Le memorie più forti però hanno bisogno di un piccolo atto di amnesia. Un evento carico di una componente emotiva risulta più facile da ricordare; è l’emozione stessa che ne segnala la salienza e quindi lo “etichetta” come un evento importante da memorizzare. In questi casi, il rilascio di adrenalina e cortisolo, e l’attivazione contemporanea di ippocampo e amigdala (struttura cerebrale coinvolta nel coordinamento delle risposte emozionali) facilitano la formazione della memoria e il successivo consolidamento. Questa memoria però, per essere funzionale non può portare con sé il carico emotivo originale e, durante il consolidamento notturno, il cervello effettua un disaccoppiamento tra la rappresentazione dell’evento (che viene rafforzata) e il tono emotivo associato (che viene indebolito). Questo processo è fondamentale per una buona regolazione emotiva, di cui il sonno diventa una parte integrante.
La deprivazione di sonno ha effetti evidenti sulla reattività emotiva, che spesso risulta esagerata, con la manifestazione di irritabilità, ansia, manie, una percezione amplificata delle emozioni negative e un aumento della sensibilità agli stimoli che attivano il sistema della ricompensa. Un’ipotesi propone che la carenza cronica di sonno possa compromettere il normale controllo da parte della corteccia prefrontale dell’amigdala e di altre strutture corticali che diventano iper-responsive, ma le evidenze al riguardo sono discordanti. Il ruolo del sonno nella regolazione emotiva è evidente considerando che i disturbi psichiatrici e dell’umore sono altamente correlati con disturbi del sonno.
Il sonno emerge dunque come fattore di rischio per numerose condizioni di malessere fisico e psicologico; un fattore di rischio che, grazie a interventi comportamentali e farmacologici, può essere modificato e diventare un alleato nella prevenzione. Chi dorme non “piglierà i pesci”, ma potrebbe decisamente vivere meglio. LEGGI TUTTO